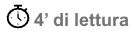
Uno degli ambiti più inesplorati, e disapplicati, nel mondo dell’ordinamento giudiziario è sicuramente quello della deontologia, ovvero della etica giudiziaria.
Che nulla a che fare con la morale, si intenda, se non nella misura in cui essa non trasfiguri il dovere costituzionale di esercitare le funzioni pubbliche “con disciplina e onore” (art. 54 Costituzione).
Si tratta di quelle regole scritte, non formalmente vincolanti, che descrivono il dover essere del magistrato, i cui valori e principi dovrebbero improntare la sua condotta nell’esercizio delle funzioni, nei rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia, con gli altri operatori del settore, con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, nonché nella vita sociale.
Mi piace assimilare questo sistema di regole a quello che nel mondo greco veniva definito Ius, per contrapporlo alla Lex, ovvero il diritto naturale rispetto a quello positivo.
Una sorta di Carta Costituzionale materiale a cui dovrebbe aspirare ogni magistrato, magari da cui fare ispirare il proprio comportamento diuturnamente.
Come tutti i dipendenti pubblici, anche i magistrati hanno dovuto, in ossequio ad una specifica norma di legge (dapprima l’art. 58 bis, d.lgs. 29/1993, successivamente l’art. 54, d.lgs. 165/2001), munirsi di un codice etico che risponda a questa esigenza.
Principale obiettivo della normativa era quello di garantire la qualità dei servizi, prevenire la corruzione e assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo all’interesse pubblico.
Si è dato seguito al dettato legislativo nel 1994, con l’adozione del codice etico dei magistrati, redatto in seno alla rappresentanza dell’Associazione Nazionale Magistrati.
Esso è particolarmente importante, anche perché è stato il primo in ambito europeo ed ha costituito un modello per tanti altri Paesi UE. Si tratta di un testo composto da 15 articoli di una chiarezza esemplare.
Tra i doveri in esso enunciati si ricorda che il magistrato opera senza indebite interferenze, sia nei rapporti esterni che nei rapporti all’interno della magistratura, e che deve preservare la propria immagine di imparzialità, evitando qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici, che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine (artt. 8 e 9).
Si ribadisce espressamente che, una volta eletto in organismi rappresentativi, il magistrato opera senza vincoli di mandato rispetto agli elettori ovvero ai gruppi associati.
Nel 2023 anche l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, nell’ambito delle sue relazioni internazionali, ha ritenuto di ratificare un “codice di condotta” per i componenti dei Consigli di Giustizia (gli equivalenti del nostro C. S. M.), che ha ribadito le regole basilari di comportamento richieste ai componenti togati di detti organismi.
Ovviamente più alta la responsabilità, più alta l’asticella etica da rispettare, più alti gli standard di integrità richiesti nella vita professionale e personale dei componenti.
Ecco perché anche detto “rule of conducts” ribadisce il dovere di correttezza indicato nel codice etico della magistratura italiana, ma esplicita concetti ancora più specifici per le funzioni dei consiglieri.
Per garantire l’integrità nell’esercizio delle funzioni di autogoverno, ad esempio, si prescrive che i singoli consiglieri non dovrebbero intercedere o consentire alcuna ingerenza a favore di qualunque individuo.
Per preservare l’indipendenza durante il mandato, poi, essi devono essere liberi da circostanze e influenze che compromettano l’adempimento dei rispettivi doveri, devono rimanere indipendenti da qualsiasi influenza interna o esterna e devono sempre evitare di ricevere indicazioni da qualsivoglia individuo, istituzione, organo o ente.
Ancora più specificatamente i componenti di consigli di giustizia dovrebbero rimanere “indipendenti gli uni dagli altri”, così come dovrebbero fare “nei confronti di ogni possibile gruppo di pressione tanto all’interno quanto all’esterno della magistratura”, specificandosi che tra tali gruppi vadano compresi “le organizzazioni professionali”.
La domanda sorge, dunque, spontanea: può dirsi deontologicamente ed eticamente corretto il comportamento del consigliere del CSM che vota sempre con il gruppo/partito/fazione che lo ha fatto eleggere o a favore di un iscritto alla sua corrente che ha presentato domanda per un incarico di qualsiasi genere?
La domanda è retorica e la risposta non può che essere negativa, perché la si trova, a chiare lettere, nel codice etico adottato dall’ANM (nel 1994!) e nelle regole di condotta che ha ratificato lo stesso Consiglio Superiore nel 2023. Quelle disposizioni dimostrano che sarebbe possibile debellare il correntismo dentro il CSM, inteso quale manifestazione della degenerazione etica della magistratura, senza dover ricorrere ad alcuna riforma costituzionale, se solo se ne facesse concreta e quotidiana applicazione nell’esercizio delle funzioni di alta amministrazione alle quali sono chiamati i consiglieri.
E la corale riprovazione dei componenti del gruppo di riferimento dovrebbe essere la più efficace sanzione.
Se la deontologia divenisse costume culturale e habitus quotidiano di ciascun magistrato, non ci sarebbe, inoltre, bisogno di procedere a quella rivoluzionaria riforma costituzionale del meccanismo di designazione dei suoi componenti che tanti auspicano, come chi scrive.
Le regole comportamentali deontologiche possono e dovrebbero diventare supporto culturale di ogni magistrato, specialmente di colui chiamato a svolgere le funzioni di componente del CSM.
Esse mi sembrano le uniche capaci, oggigiorno, di diventare lo strumento di una seria autoriforma della magistratura e il miglior modo per recuperare credibilità e autorevolezza perse nel corso degli ultimi anni e dopo gli ultimi scandali, e, come sottolineato nello stesso codice di condotta del CSM, il sistema per costruire e promuovere la fiducia dell’opinione pubblica nella magistratura.
