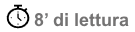
Il convegno svoltosi qualche mese fa, auspice il prof. Roberto Serrentino, sulla riforma Cartabia ed in particolare sulla Giustizia riparativa, fornisce degli spunti di riflessioni (d. lgs n. 150/22, inserito nel c.p.p. all’art.129-bis).
La riforma ha introdotto un principio nuovo: la possibilità di avviare, nel corso di ogni stato e grado di giudizio penale, un programma di giustizia riparativa, che consente di partecipare, all’indagato o all’imputato ed a tutte le vittime o loro eredi, ad incontri per la risoluzione, con l’aiuto di un terzo mediatore, delle questioni derivanti dal reato. Per “questioni”, espressione molto generica, si presume debba intendersi anche il risarcimento dei danni subiti dalle vittime del reato. E cos’altro?
Si tratta di un’innovazione non di poco conto, dalla quale si deduce che il reato non è più visto soltanto come una violazione delle norme ordinamentali preposte al fine di garantire la pace sociale, il che comporta innanzi tutto la comminazione di una pena per l’imputato ritenuto colpevole, cui fa seguito, a carico di costui, l’obbligo di risarcire i danni materiali e morali subiti dalla persona offesa o suoi eredi.
Lo stesso illecito penale viene ora strutturalmente concepito in rapporto a queste ultime alle quali in via prioritaria vanno risarciti quei danni. Esse di conseguenza assumono un ruolo più diretto in quanto interlocutrici che con la loro manifestazione di volontà possono incidere sullo svolgimento del processo. Tutto ciò anche su iniziativa del giudice e prima di qualsiasi sentenza che si sia pronunciata sulla responsabilità penale del presunto autore del reato. Si prevede soltanto che lo stesso giudice possa valutare la utilità del programma dal quale non derivi un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.
Non c’è il rischio che sull’altare della vittima possano vacillare alcuni principi fondanti il nostro processo penale?
Questa impostazione è in armonia con la filosofia dei sistemi d’oltre oceano, fatta propria dalla Unione Europea che più volte, con raccomandazioni o direttive, ha però auspicato soltanto una disciplina di diritto convenzionale degli Stati membri, che garantisse un risarcimento alle vittime del reato e segnatamente per i casi in cui l’autore dello stesso reato rimanga ignoto o per le ipotesi di non adeguato risarcimento.
È difficile prevedere se questa novella potrà determinare un ulteriore ampliamento o un freno, come sarebbe auspicabile, al protagonismo dilagante della vittima del reato, in crescita negli ultimi tempi, sia dentro che fuori le aule di Giustizia e che costituisce un’alterazione della dialettica processuale.
Si tratta di un fenomeno agevolato dalla penetrante e talvolta eccessiva opera dei mass media che, dando quasi per scontata la responsabilità della persona accusata, individuano nella vittima l’unico soggetto di attenzione, che attende giustizia ad ogni costo. L’opinione pubblica appare sempre più coinvolta e disponibile alla condivisione. Incidono l’innata posizione colpevolista dell’essere umano e ovviamente anche la reiterazione di fatti criminosi che turbano le coscienze e portano ad una immediata solidarizzazione con la vittima, prima di qualsiasi avvio di indagini. Si condivide la sommaria identificazione dell’autore del fatto criminoso, come prospettato, con il risultato di un’esaltazione della vittima che, lungi dallo scoraggiare la reiterazione di fatti di violenza (perché di questo si tratta) può rappresentare addirittura uno stimolo.
Va da sé – sia detto una volta per tutte- che non si intende assolutamente sminuire il disvalore sociale di questa che è divenuta una deriva ed una piaga sociale che può rientrare solo con iniziative politiche di grosso spessore e non ponendo il mostro in prima pagina, laddove nei casi di violenza il mostro è addirittura la vittima. Né spinge a formulare queste osservazioni una concezione riduttiva del ruolo processuale delle parti civili volto ad ottenere comunque un adeguato risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Si auspica soltanto una diversa e più serena attenzione, scevra da frettolose valutazioni verso le vittime, non disgiunta dalla esigenza di rispettare comunque e sempre i diritti del presunto responsabile, anche dopo la eventuale sentenza di condanna.
Ci si chiede però in quale direzione vada il progetto di riforma costituzionale, approvato lo scorso anno da un ramo del Parlamento, che prevede l’aggiunta, in calce all’art.111 della Costituzione, del seguente capoverso:
“La Repubblica tutela le vittime del reato”.
In verità si è discusso prima in ordine al collocamento dello stesso emendamento: se inserirlo cioè in calce all’art.111 o all’art. 24. Né l’una né l’altra ipotesi convince.
Rispetto a quest’ultima sarebbe un’inutile ripetizione pleonastica, attesa l’ampia dizione dello stesso articolo che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
Convince poco pure la prima ipotesi. Si ravvisa la medesima superfluità, data la potestà punitiva dello Stato che non incontra limiti di sorta nel nostro ordinamento e che non abbisogna di alcun rafforzamento.
La nostra Costituzione contiene norme primarie che fungono da raccordo di quelle ordinarie, consentendo l’espunzione di queste ultime non in armonia con lo spirito della Carta. Inserire pertanto norme superflue che nulla aggiungono al riconoscimento di diritti già tutelati, non rende buon servigio alla stessa Costituzione.
Si verificherebbe inoltre quanto paventato, in un suo pregevole scritto, dal prof. Manes che ha sottolineato: “..previsione ambigua… che può rappresentare il primo, scivoloso passo verso un generalizzato diritto di ottenere la punizione del colpevole che andrebbe comunque garantito alla vittima. Un definitivo congedo dal modello reocentrico a favore del modello vittimocentrico e dallo stesso modello liberale del diritto penale che non riconosce nella pena l’unica risposta al reato, né nella punizione l’unica forma di compensazione delle vittime”.
È questa la deriva che preoccupa e che può smantellare i cardini del processo che vede spostato il suo baricentro dall’accertamento della responsabilità dell’imputato – presuntivamente innocente e che, se condannato, determina la esistenza della vittima processuale -, al riconoscimento della persona offesa. Si realizza un circuito opposto e contrario. La vittima è già nella realtà processuale, in alcuni casi immanente, ove prevista la irrevocabilità della querela. Ci si orienta sempre di più verso la concezione secondo la quale deve esserci comunque un colpevole. La parte lesa non chiede giustizia, ma condanna, alla cui fonte viene nutrito, fuori dalle aule, un sentimento di vendetta che deve rimanere estraneo alla nostra cultura ed al sistema giuridico. Il processo mediatico fa la sua parte ed alla fine il giudice può sentirsi in qualche modo condizionato. Si può correre il rischio che lascia più sereni la condanna. Assolvere diventa più difficile.
A parte gli “idola tribus” di leibneziana memoria, Hobbes affermava che la condanna assomiglia alla giustizia ben più che l’assoluzione.
Non sono rari i casi in cui le sentenze di condanna, per qualsiasi reato che abbia determinato un allarme sociale, vengono accolte con applausi e quelle di assoluzione con fischi e con commenti, enfatizzati dai mass-media, come: “Me l’hanno ammazzato due volte (…) questa non è giustizia”.
Ci si avventura addirittura a contestare l’impianto di difesa dell’imputato, ponendo dei limiti di ragionevolezza sull’uso di espressioni che solo il Presidente della Corte giudicante può valutare e contro
Si è propensi a ritenere che la pena più alta debba essere quella esemplare, mentre i fatti, la storia, dimostrano che sia l’inasprimento della stessa o l’introduzione di nuovi reati non comportano la riduzione della criminalità.
È stato creato di recente il reato di femminicidio. Inutile sottolineare che la reiterazione di episodi che vedono vittime donne mogli, fidanzate, conviventi o partner di soggetti violenti è diventata una piaga sociale che allarma giustamente l’opinione pubblica e che impone soluzioni.
Ci si chiede soltanto se questa soluzione sia quella giusta e quali effetti deterrenti essa possa comportare. Intanto si pongono delle premesse per una netta discriminazione.
Un uomo che toglie la vita ad una donna potrà rispondere sia di femminicidio che di omicidio ex art. 575 c.p. nel caso si sia al di fuori delle ipotesi di non facile interpretazione soprattutto ove si fa riferimento alla “… repressione dell’esercizio dei diritti, delle libertà o dell’espressione della personalità della persona offesa”, previste dal reato di femminicidio. Ma l’omicidio di cui all’art. 575 non include anche queste ipotesi?
Una donna risponderà sempre e comunque del reato di omicidio, anche se ricorrono in astratto le condizioni previste per il femminicidio.
La creazione di questo nuovo reato ubbidisce, a parte gli effetti mediatici catturanti il consenso, soltanto alla ritenuta esigenza di assicurare la pena massima edittale, su cui da tempo si concentrano critiche anche di ordine costituzionale.
In conclusione, tra i vari episodi che potrebbero citarsi, si fa solo un breve cenno alla sentenza della Corte di assise di Venezia di poche settimane fa che, pur avendo condannato all’ergastolo l’imputato Filippo Turetta per l’omicidio (all’epoca ancora tale) di Giulia Cecchettin, riconoscendo l’aggravante della premeditazione, ha escluso l’altra contestata aggravante della crudeltà, malgrado l’imputato avesse inferto alla vittima ben 75 coltellate.
Ovviamente la efferatezza del delitto e le modalità di esecuzione hanno frastornato l’opinione pubblica che chiedeva piena giustizia ed ancora una volta, specialmente da parte dei non addetti ai lavori, si è gridato allo scandalo per la marginale esclusione di detta aggravante. Eppure era stata fatta giustizia, con la condanna dell’imputato alla pena massima, dato il quadro probatorio conosciuto e le dichiarazioni dell’imputato.
Sembra sia stato proposto appello. Si attenderà una nuova decisione.
È solo il caso di far presente che questa questione era già stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza. La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte e, nella quasi totalità dei casi, ha escluso nelle stesse fattispecie (reiterazione di colpi inferti alla vittima) la richiamata aggravante della crudeltà, ritenendola di tipo soggettivo che può prescindere dalle modalità di esecuzione del delitto.
È una questione particolarmente delicata e non può essere certamente valutata in base alla concezione volgare o se si vuole semantica del concetto di crudeltà.
Quella giuridica è affidata all’art. 61 n.4 c.p. e rientra nelle circostanze aggravanti, non facente parte quindi della struttura del reato. Una circostanza che unitamente all’uso delle sevizie, presuppone un dolo specifico estraneo alla semplice volontà omicida, finalizzato ad aggravare con particolari azioni le sofferenze della vittima, che si aggiungono a quelle volute, ma inutili, per determinare l’evento morte. Anche se l’azione ha raggiunto il risultato di ulteriori angosce materiali o morali, l’aggravante può essere esclusa a prescindere dalla ritenuta o meno compatibilità con il dolo d’impeto o l’efferatezza, quest’ultima riconosciuta dalla sentenza in esame. La Corte ha fatto questa valutazione, suffragata da numerose decisioni sul punto.
L’espressione, peraltro un po’ infelice, usata in sentenza relativa alla “inesperienza nella consumazione del delitto” era stata già adottata dalla perizia di ufficio, per cui un più puntuale uso dei termini avrebbe evitato la facile ironia sulla necessaria esperienza per compiere un delitto.
La pietà per le vittime ubbidisce ad un sentimento certamente laico prima che religioso. Si ritiene che anche i responsabili dei peggiori crimini (non so se anche quelli di genocidio) meritino quella “Pietas romana” che dovrebbe accompagnarci nel corso della storia.
