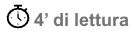
Tiene banco da giorni nel dibattito pubblico – e non solo sui tavoli degli addetti ai lavori – il famigerato DL Sicurezza1 che, con buona pace di ogni idea liberale del diritto e del processo penale, costruisce nuove fattispecie criminose, aumenta le pene, introduce nuove ostatività nella fase della esecuzione.
E lo fa, peraltro, sperimentando inusitate latitudini concettuali che agganciano i suoi sbandierati obbiettivi securitari non ai fatti in sé, ma ai luoghi della loro commissione o alle caratteristiche dei loro autori.
L’esperimento, diciamolo subito, è fallito. Per ragioni di metodo e di merito.
Sotto il primo profilo, intanto, pur avvezzi allo smodato ricorso alla decretazione di urgenza, che ha da tempo attecchito indistintamente a destra come a sinistra, non possiamo che registrare un deciso passo in avanti, che sposta ulteriormente un limite invece indispensabile per gli equilibri democratici.
È vero, in termini generali, che la decretazione governativa altera in certa misura la fisiologia dei rapporti tra il potere legislativo e quello esecutivo, accreditando il secondo di una facoltà che normalmente spetta solo al primo. Tuttavia, il disposto costituzionale che legittima quello sbilanciamento solo in ragione della straordinaria necessità ed urgenza che deve connotare l’atto legislativo del governo, come pure la necessità di una ratifica parlamentare successiva, tengono insieme il sistema evitandone la rottura.
In siffatto contesto, è già difficile digerire l’abuso2 della decretazione e più ancora la scure della apposizione della fiducia che castra il dibattito in sede di conversione.
Sennonché – ed è questo il dato innovativo – nel caso del DL Sicurezza il Parlamento non è stato solo privato delle sue prerogative, ma ha dovuto subire lo schiaffo istituzionale di una sottrazione in corsa dell’oggetto della riflessione: introdotto dal Governo un disegno di legge pervenuto già alla terza lettura del Parlamento, quello stesso testo è confluito in un decreto-legge che ha di fatto impedito all’organo legislativo di completare la meditazione già incominciata. Che se poi questo testo fosse blindato – come non è difficile preconizzare – dalla questione di fiducia, si fa presto a capire quale nuovo sgangherato scenario costituzionale i fatti narrati disegnano.
Né le cose van meglio, sotto il secondo profilo, quello di merito.
Coloro che rinunciano a libertà fondamentali in cambio di scampoli di sicurezza temporanea non meritano né libertà né sicurezza.
Suona più o meno così la traduzione di un noto aforisma attribuito a Benjamin Franklin3 che appare, almeno di primo acchito, come l’esergo perfetto per condensare tutto il discorso attorno al contenuto di questo testo, che interroga i giuristi e affatica i penalisti italiani. Sul tema, infatti, in seno alla astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, la Camera Penale di Roma ha organizzato una partecipata manifestazione pubblica in Piazza Cavour il 5 di maggio, che ha visto l’intervento accorato di politici, avvocati, costituzionalisti e cittadini, alternatisi al microfono per tre ore piene.
E, in effetti, il testo del Decreto sembra per davvero sacrificare libertà essenziali (quali, fra tutte, quella di manifestare pacificamente il proprio dissenso) con l’intento di garantire migliori sicurezze per i cittadini.
Ora però, due considerazioni sembrano possibili.
Intanto che, già a partire dalle parole di Franklin, la riflessione politica dovrebbe condurre a ripensare il contenuto del Decreto, non sembrando potersi stabilire alcuna relazione di proporzionalità inversa tra Libertà e Sicurezza e, anzi, potendosi pure dubitare che Libertà e Sicurezza siano due valori e non invece un valore la prima e una mera percezione la seconda4.
Ma poi – e questo sembra lo snodo centrale – che se anche quella relazione potesse fondatamente instaurarsi, qui non è di Sicurezza che parliamo per davvero, quanto di un suo simulacro, originato da nient’altro che da una farlocca narrazione politica (e spesso anche giornalistica) tinteggiata ad arte che, piuttosto che centrarsi sui dati effettivi, indulge a racconti di comodo animati dal malcelato scopo di creare quegli stessi timori che misfatti legislativi come quello di cui si discute provvederanno poi a curare.
Insomma, anche se la Sicurezza fosse per davvero un valore, dovremmo diffidare della pretesa di compararla alla Libertà contemperando questa con quella.
Mentre se essa sia, come forse più accurato, nient’altro che la percezione di un rischio, in quanto tale mai possibile fondamento della legislazione penale, non potremmo che concludere che quella comparazione è fittizia e la norma che pretende di praticarla costituzionalmente sbilenca.
1. Decreto Legge n. 48 del giorno 11 aprile 2025.
2. La percentuale di norme originate da decreti-legge nella XIX legislatura, che si aggira attorno al 40%, apre essa stessa un fronte serissimo di dubbio sulla reale necessità ed urgenza di una così vasta produzione normativa.
3. “Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety”, Risposta al Governatore, Assemblea della Pennsylvania, 11 novembre 1755; in The Papers of Benjamin Franklin, ed. Leonard W. Labaree, 1963, vol. 6, p. 242.
4. Intuizione raffinata di Iacopo Benevieri, in uno scambio privato di ragionamenti.
